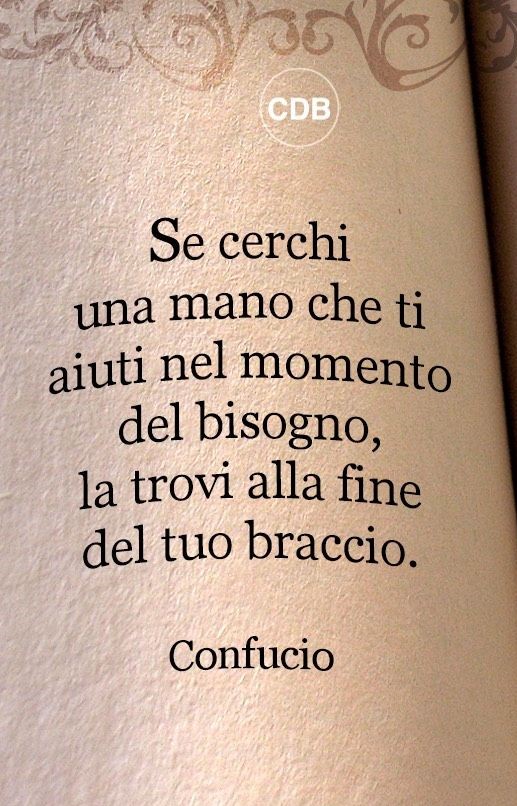Sto rileggendo una pagina del libro Cancrini- Vinci, Conversazioni sulla Psicoterapia, con la stessa passione di allora alla luce dell’esperienza accresciuta di oggi e la trovo vera, significativa, saggia.
Il sentimento di utilità in psicoterapia
Cancrini – Vinci
CANCRINI E per te, invece, quali sono le gioie e i dolori della professione?
VINCI L’aspetto gioioso è rappresentato dal sentimento dell’utilità che provo quando vedo che la relazione d’aiuto sta cominciando a dare i suoi frutti, e la persona sta recuperando la capacità di utilizzare parti più evolute di sé. Tanto più quando questo riguarda genitori che si occupano meglio dei loro figli, o figli diventati adulti che cominciano a guardare la propria storia con più compassione e benevolenza, e per questo si rendono più capaci di guardare avanti. Il sentimento dell’utilità è il piacere di essere strumento che si presta a far qualcosa per chi lo utilizza ed è, nel suo piccolo, un sentimento di pienezza: la soddisfazione della tenaglia che estrae un chiodo e rende la tavola riutilizzabile, o della pinzetta che estrae una spina da un punto doloroso. Tenaglia o pinzetta ben funzionanti, s’intende, dotati di un’anima consapevole e capaci di auto-manutenzione (si spera), ma pur sempre strumenti nelle mani di chi decide di usarli. E a proposito di strumenti, mi riconosco molto in quel che Primo Levi in La chiave a stella fa dire al suo protagonista, un operaio molto bravo: «Se si escludono istanti prodigiosi e singoli che il destino ci può donare, l’amare il proprio lavoro (che purtroppo è privilegio di pochi) costituisce la migliore approssimazione concreta alla felicità sulla terra: ma questa è una verità che non molti conoscono“. La cosa penosa di questo lavoro sul piano personale è per me il timore, tutte le volte che mi pare insoddisfacente l’andamento del processo terapeutico, di non essere stato attento, pronto, competente quanto quella situazione specifica avrebbe richiesto. Però quel timore è anche un buon propellente per andare avanti e far meglio, per provare a capire di più. Magari per diventare anche più saggi.
Cancrini – Vinci, Conversazioni sulla psicoterapia – Alpe

Commento
Anche per me il sentimento di utilità è quello che mi conforta e mi ha confortato ad andare avanti negli anni, anche se la percezione di essere stato veramente utile l’ho avuta solo in pochissimi casi che si possono contare quasi sulle dita di una mano. E mi fanno dire: ne vale la pena andare avanti, fino a quando qualcuno ancora bussa alla porta o chiama. Anche se è antieconomico tenere la porta aperta per quei pochi che si fanno vivi. Chiuderò la porta quando la mente e le forze non me lo permetteranno di essere utile. Quando non avrò più niente da dire per poter aiutare l’altro. O quando si esaurisce la passione che mi spinge ad essere quello che sono. Come l’operaio di Primo Levi, ho fatto l’esperienza, rara nella vita, di aver fatto due mestieri: il primo per necessità, (come capita a tutti), l’insegnante per trent’anni, il secondo per scelta, lo psicoterapeuta da trent’anni e ancora in attività. Entrambi amati, e nel secondo riconosco la presenza del primo. Perciò posso dirmi fortunato.
Non faccio più corse per apparire, per essere in vetrina. Accetto di prendere in carico solo quelli che chiedono, perché indirizzati da altri che sono passati per quella porta. E solo ad una condizione, che siano fortemente convinti di intraprendere con me questo percorso di conoscenza di sé e delle cause sconosciute che fanno star male. Ho imparato che la psicoterapia è efficace solo se si crea quella sottile intesa relazionale fra me e l’altro che si affida a me e che mi impegna e mi responsabilizza ad assumermi una funzione di “cura” e di “ricerca”. Se cioè si riesce a creare una intesa, una alleanza terapeutica fra terapeuta e paziente, ognuno con il suo ruolo operativo, che al di là della tecnica usata, assicura una maggiore percentuale di esiti positivi
Perciò prima di impegnarmi in una terapia, da alcuni anni faccio lungo colloquio conoscitivo del problema e della sua storia sintomatica, informativo della tecnica della psicoterapia familiare e relazionale, della presentazione di chi sono io di cosa posso fare per lui. Mi piace spiegare chi sono, cosa faccio, come lo faccio e cosa posso fare e se posso fare per lui. Non ho resistenze a parlare di me e della mia storia. Me lo posso permettere, la mia età e l’esperienza mi fanno essere libero in questo, perché sono convinto che la psicoterapia è una relazione ed un incontro, e in una relazione sana e autentica il coinvolgimento è necessario, pur nel rispetto della diversità di ruolo e di persona. Così dopo la prima seduta, lascio andare l’altro con il bagaglio di quanto ci siamo detti, raccomandandogli di pensare e riflettere, e solo dopo, quando ne è maggiormente convinto, può telefonare per iniziare il percorso. L’altro se ne va forse ancora più confuso, quando lo accompagno alla porta, senza pagare, per questo, “l’onorario”, perché sono convinto che l’ascolto dell’altro non ha prezzo, non è mestiere. E anche se, come succede, l’altro non si fa più vivo, e sono i più, mi piace pensare di essergli stato utile in qualche modo anche se solo con l’ascolto.
Il “mestiere” comincia dopo, quando deciderà lui. Ed è un mestiere difficile, impegnativo, è una esplorazione e un viaggio senza bussole rassicuranti, è una ricerca paziente e convinta di quello che non si vede, dei segni nascosti, che richiedono di essere portati alla luce per dare senso a quello che senso apparentemente non ha.
Ed è un viaggio in cui si possono incontrare tranelli, inciampi, scivoloni, sentimenti di impotenza, nonostante l’accortezza e l’esperienza. Non tutto e non sempre fila liscio in una psicoterapia, specialmente quando si pensa di sapere e di saper fare dovuto alla lunga esperienza. Perchè la verità è che la persona è unica e non un modello, non è un “caso” clinico, ma una individualità con una sua storia personale e familiare unica che ogni volta ti fa dire “è sempre una prima volta”. Perciò trovarsi in un fallimento, in un apparente non saper fare, in un intoppo, e fare i conti con una delusione, con lo sconforto “di non essere stato attento, pronto, competente quanto quella situazione specifica avrebbe richiesto”, non è raro. Anzi credo più frequente di quanto non si crede. Solo che in psicoterapia nella letteratura e nelle comunicazioni ufficiali i fallimenti non hanno dignità conoscitiva. Ma so anche che possono essere invece, almeno per me è così, se c’è passione e amore per la cura, uno stimolo potente per fare ricerca e conoscenza di quel che non si sa, ma anche prendere atto umilmente dei propri limiti, senza sentirsi schiacciati per questo dal senso di inutilità e di impotenza.
E anche se, come succede, l’altro non si fa più vivo, mi piace pensare di essergli stato utile in qualche modo.