
Per dire semplicemente «io sono qui, tu dove sei?», come i cuccioli appena nati che cercano la madre …
«lo sono qui, tu dove sei?»
Per un bambino di un anno e mezzo, una settimana corrisponde a quasi otto mesi. Ormai gli esperti ne sono certi.
Ma allora per quanto tempo mamma mi ha abbandonata? Faccio un rapido calcolo. Quasi due anni… Proprio quando avrei dovuto imparare a «stare su» da sola. Proprio quando avrei dovuto fare l’esperienza dell’assenza progressiva della madre.
E invece sono passata dal «tutto» al «niente». Perché prima di essere ricoverata in ospedale, mamma non mi lasciava mai. E quella mattina, quando mi sono svegliata e lei non c’era …
È una storia banale. Chissà quanti bambini hanno vissuto la stessa cosa ..Ma nel mio caso qualcosa è andato storto. Naturalmente non ricordo nulla. La storia mi è stata raccontata. Ma ogni volta che la ascolto mi viene da piangere. E la rivivo costantemente, ogni volta che mi innamoro.
Mamma era stata ricoverata e se ne era andata mentre dormivo. All’epoca, pare che fosse normale non dire nulla ai bambini. E poi mamma era già sufficientemente angosciata all’idea del distacco che parlarne con me doveva sembrarle impossibile. Fatto sta che, l’indomani mattina, mamma non c’era. E l’indomani nemmeno. E il giorno successivo nemmeno. E così via. Per tre settimane, non me l’hanno mai fatta vedere.
Le parlavo solo al telefono. Ma pare che a quell’ età il telefono non serva a granché, anzi, pare che peggiori la situazione perché il suono della voce e l’assenza fisica destabilizzano ancora di più.
Non so se il mio odio per il telefono risalga a quegli anni. Ma quando penso alle crisi di pianto telefoniche con gli uomini che ho amato e che ho perso – quasi sempre dopo un’assenza prolungata – mi convinco una volta di più che la coazione a ripetere è un demone da cui nessuno riesce a liberarsi… come per «riparare» quello che è successo … anche se non ripariamo proprio niente … e per vivere veramente dovremmo smetterla di voler riparare il passato.
Quando la vicina di casa veniva a vedere se tutto andava bene, pare che la portassi nella camera da letto di mamma, per farle mettere la sua vestaglia. Quando mamma è tornata a casa, pare che all’inizio non volessi avvicinarmi.
Quando mi sono ritrovata tra le sue braccia, pare che non la volessi più lasciare. Quando la sera è arrivato il momento di andare a letto, pare che avessi delle crisi di pianto.
«Piangevi appena mi allontanavo.»
«E poi?»
«Volevo restarti accanto fino a che non ti fossi addormentata. »
«E poi?»
«Tuo padre non voleva.»
«E poi?»
«Hai smesso di piangere e ti sei addormentata»
Michela Marzano, Volevo essere una Farfalla Pag. 121
*** *** ***
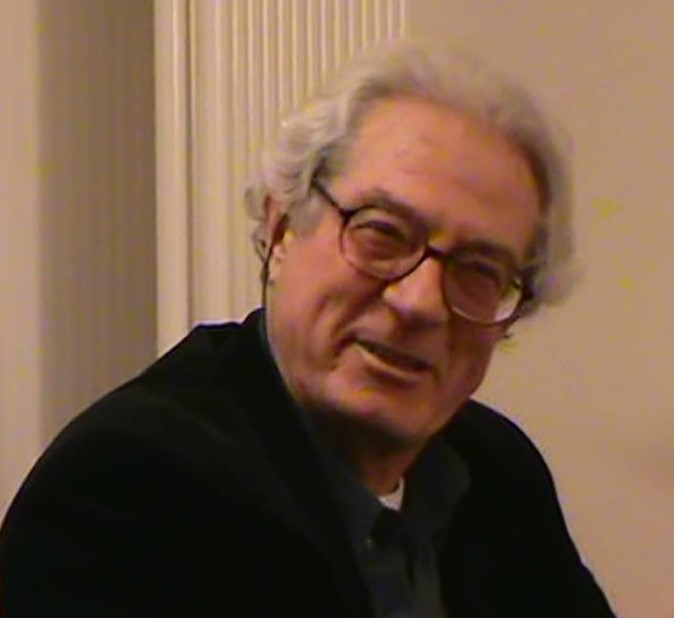
“Io sono qui, tu dove sei?
È il bambino che chiama impaurito, che ha paura della solitudine, che cerca la sua figura di attaccamento che risponda al suo bisogno di sentirsi rassicurato. Se la risposta tarda a venire, il richiamo esplode in pianto disperato, oppure se la risposta non arriva, a lungo andare il bambino smette di piangere e si chiude in un silenzio muto. “Hai smesso di piangere e ti sei addormentata”.
Tutto ciò avviene gradualmente in una sequenza continuata nel tempo, fatta di richiami e assenza di risposte. Così il bambino apprende che non può contare sulla presenza della figura di accudimento, o almeno non sempre. Apprende anche a bastare a se stesso, a non chiedere aiuto, se non in casi eccezionali, quelli vitali, che hanno un valore di sopravvivenza per lui. Diventerà lungo andare un bambino “evitante”, secondo la teoria dell’attaccamento
Se poi la sua figura di attaccamento, non solo non risponde, ma sparisce in modo immotivato per un lunghissimo tempo (Per un bambino di un anno e mezzo, una settimana corrisponde a quasi otto mesi), allora il bambino subisce un trauma da abbandono, e si percepisce di essere stato rifiutato dalla madre. Se ricompare improvvisamente, come improvvisamente è sparita, la madre è apertamente rifiutata (Quando mamma è tornata a casa, pare che all’inizio non volessi avvicinarmi).
“Io sono qui, tu dove sei”
Implorazione che vale anche nella relazione d’amore, quando l’amata sente che l’amato è distante, non cammina accanto a lei, non lo sente vicino, è quasi assente o sta prendendo altre vie. Si interrompe la comunicazione relazionale, anche se la comunicazione abbondante del quotidiano può essere fuorviante, nascondendo la mancanza del dialogo interiore. L’una sente che l’altro non si prende cura di lei, non risponde alle sue richieste e alle sue aspettative.
Io sono qui, ma tu non ci sei, e non so dove sei. In questa condizione di incertezza, si fa strada la paura dell’abbandono, del rifiuto e comunque il sentire di non essere amata. L’altro viene percepito come uno sconosciuto, i suoi movimenti sono incomprensibili, i suoi silenzi sono assordanti. Sentimenti che si ripetono e accompagnano la relazione d’amore adulto e soprattutto se nell’infanzia il bambino ha vissuto un reale trauma di abbandono.
Solo che nella relazione adulta soprattutto vale la reciprocità. “Se tu sei lì, dove sei sempre stata, perché non sei dove sono io adesso? Il “dove” siamo stati inizialmente non può immobilizzare la relazione, il “dove” è solo una tappa del percorso non la meta. E comunque serve sempre lanciare il grido di allarme “Io sono qui, tu dove sei?” per recuperare l’intesa relazionale, per ridurre la lontananza, per cominciare a fare i conti che non si sono fatti.
“Io sono qui, tu dove sei?”, vale anche per la relazione terapeutica, è l’aspetto etico del farsi carico dell’altro, anche se non è scritto da nessuna parte. E siccome stiamo parlando di sofferenza, questa non la si può ridurre a semplice sintomo curabile o eliminabile con tecniche terapeutiche. Il sintomo è il non detto che aspetta di essere nominato e capito. Il sintomo è la difesa soggettiva dalla sofferenza. Se l’altro non si fa vivo, o se ne va, non può lasciare indifferenti e non chiedersi perchè, non assumendosene la responsabilità. Sono stato fermo io, mentre l’altro aveva bisogno di muoversi? o è l’altro che da lontano manda segnali che io non so interpretare? Tutto questo fa parte sia della relazione terapeutica e della alleanza terapeutica.
Tante possibili domande, tante possibili risposte. E contemporaneamente mi son chiesto perchè tanta apprensione per questo silenzio. Di questa almeno una risposta me la sono data. Credo sia una risposta di etica professionale insita nella relazione terapeutica del farsi carico, del prendersi cura dell’altro che si affida a te. E L’altro non è mai uno qualsiasi, ma è sempre un nome che identifica una persona e il suo vissuto. Chiedersi cosa è successo, domandarsi dove sta l’altro e come sta, vuol dire prendersi cura di lui.
E in psicoterapia ci sono abbandoni comprensibili di cui il terapeuta se ne fa carico, riconoscendo in parte la sua responsabilità, e abbandoni incomprensibili, anche se legittimi, che rimangono come piccole ferite aperte, su cui, almeno io, continuo a interrogarmi e capirne le motivazioni.
Abbandoni non rari di cui si parla poco nella letteratura psicologica.