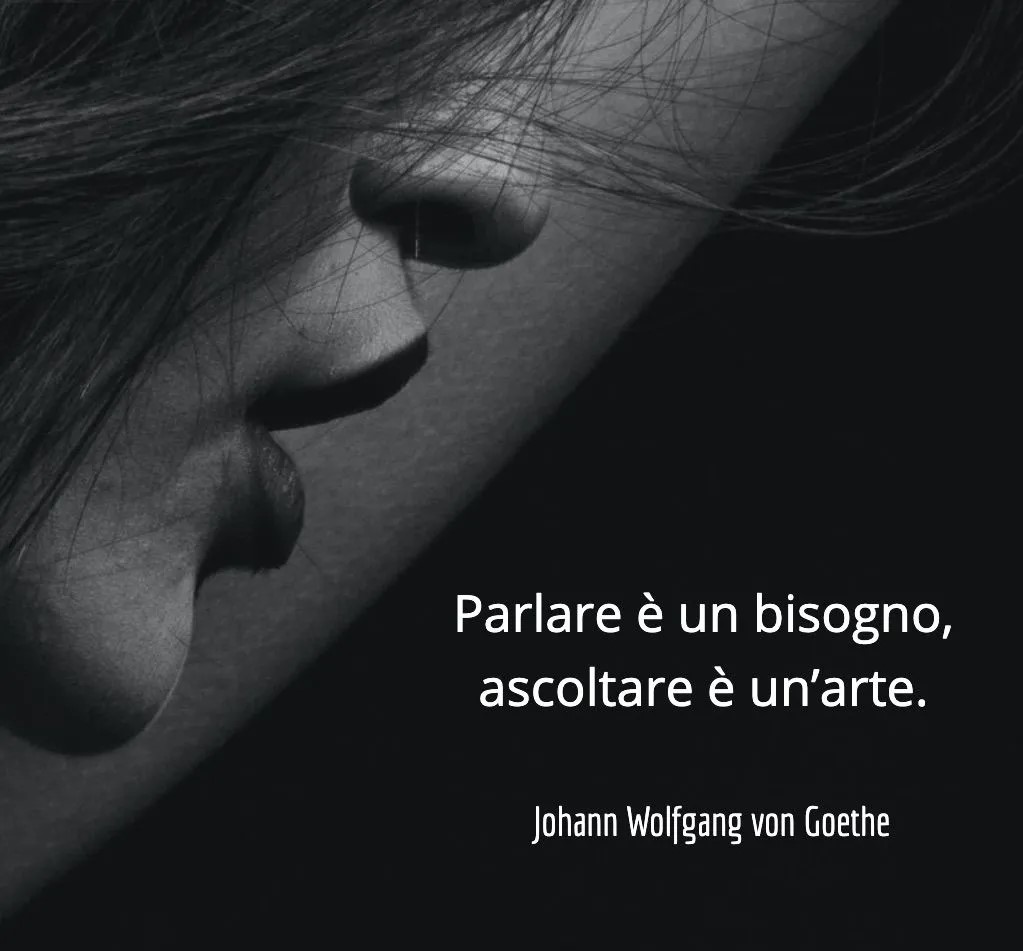Scrivere significa capire e amare le vite degli altri
David Grossman
David Grossman, che ha ricevuto il Premio per la tolleranza del Museo ebraico di Berlino, spiega perché fare letteratura è un atto politico che nasce da un profondo esercizio di comprensione. Anche dei propri “nemici”
[…] Vi racconterò una piccola storia.
Poco più di dieci anni fa ero impegnato nella stesura del romanzo A un cerbiatto somiglia il mio amore la cui protagonista, una donna israeliana di nome Orah, si allontana da casa per sottrarsi alla notizia della morte del figlio in guerra. Dopo avere scritto di Orah per circa due anni e avere lottato con lei, avevo ancora la sensazione di non riuscire a capirla veramente. Di non conoscerla come uno scrittore dovrebbe conoscere il personaggio di cui scrive. Non percepivo in lei quel fremito di autenticità, di verità e di vita senza il quale non posso credere nel personaggio che narro, essere quel personaggio. Alla fine, non avendo scelta, ho fatto quello che ogni bravo cittadino nella mia situazione avrebbe fatto: mi sono messo a tavolino e ho scritto una lettera a Orah. Una lettera semplice, come si faceva una volta, con carta e penna, dal mio cuore al suo.
E nella lettera le ho chiesto: Orah, che succede? Perché mi respingi in questo modo, perché non ti concedi a me? Ma ancor prima di completare la prima pagina ho capito il mio grande errore: non era Orah che doveva concedersi a me. Ero io che dovevo concedermi a lei. In altre parole, dovevo smettere di opporre resistenza alla possibilità che Orah esistesse dentro di me. Lasciarmi andare con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutto il corpo alla possibilità che dentro di me ci fosse una donna. Quella particolare donna. Dovevo lasciare che le particelle del mio spirito fluissero liberamente, senza freni e senza paura, verso la potente calamita di Orah e la femminilità che irradiava. Da quel momento in poi Orah ha quasi scritto se stessa da sola. La creazione è la possibilità di toccare l’infinito. Non un infinito matematico o filosofico: un infinito umano.
Gli infiniti volti dell’uomo, le infinite pieghe della sua anima, i suoi infiniti pareri, opinioni, istinti, abbagli, piccolezze, grandezze, forze creative e distruttive, le sue infinite combinazioni. Quasi ogni mia idea su un personaggio di cui scrivo mi apre innumerevoli possibilità, innumerevoli tratti del suo carattere: un giardino di sentieri che si biforcano. È quasi banale emozionarsi per qualcosa di tanto scontato, ma oggi concedetemi di farlo: noi – noi tutti – siamo pieni di vita. In ognuno di noi ci sono illimitate possibilità e modi di essere, di vivere. Ma forse questa non è affatto una cosa scontata. Forse è qualcosa che dovremmo ricordare continuamente a noi stessi. Guardate infatti quanto stiamo attenti a non vivere la profusione che è in noi, tutto ciò che le nostre anime, i nostri corpi e le circostanze della nostra vita ci offrono. Molto in fretta, già ai primissimi stadi della vita, ci raggrumiamo, ci riduciamo a essere “uno”: un solo corpo, una sola lingua (o al massimo due) con la quale diamo un nome alle cose, un solo genere. Ognuno di noi racconta una propria “storia ufficiale” tra le tante possibili, che talvolta si trasforma in una prigione. E quello di trasformarci in prigionieri della storia ufficiale che ci raccontiamo è un pericolo, peraltro, in agguato non solo per gli individui ma per intere società, stati e popoli.
Scrivere è un movimento dell’anima contro quella riduzione, contro la rinuncia alla profusione.
La creazione letteraria è il movimento sovversivo dello scrittore, in primo luogo contro se stesso. Più prosaicamente potrebbe essere paragonata a un massaggio che lo scrittore fa di volta in volta, ostinatamente, alla propria cauta, inibita e impaurita coscienza. Per me, scrivere significa essere libero di muovermi con agilità e leggerezza lungo l’asse immaginario tra il bambino che ero e il vecchio che sarò, tra l’uomo e la donna che sono, tra sanità mentale e follia, tra il me israeliano e il palestinese che sarei potuto essere se fossi nato 500 metri più a est. E sono sicuro che dal momento in cui concederemo a noi stessi di percepire questa libertà di movimento (e l’arte è un modo meraviglioso per farlo) toccheremo anche l’essenza della tolleranza politica in tutte le sue declinazioni: nei conflitti tra i popoli come nella sfida posta dai profughi che affluiscono in Europa. La tolleranza nasce dalla disponibilità di sentire e comprendere l’altro dentro di noi, anche quando l’altro ci minaccia perché è diverso, e incomprensibile. Anche quando l’altro è nostro nemico dichiarato. […]
© David Grossman https://www.repubblica.it/protagonisti/David_Grossman
Traduzione di Alessandra Shomroni
*** *** ***
Commento
“La tolleranza nasce dalla disponibilità di sentire e comprendere l’altro dentro di noi”, asserisce David Grossman.
Ma chi è l’altro dentro di noi? E cosa vuol dire che è dentro di noi? Certo ognuno di noi ha la percezione e la consapevolezza di essere unico. Di quale altro ci parla allora David Grossman?
Ma di chi se non dell’altro che avremmo potuto essere, ma che senza volerlo e senza saperlo abbiamo scartato, alienati dal fascino, dall’educazione, dall’esperienza sociale dell’io unico vincente, chiuso nella sua torre d’avorio. Così nel tempo perdiamo la nostra elasticità psicologica di poter essere e vivere altre parti di noi, “Molto in fretta, già ai primissimi stadi della vita, ci raggrumiamo, ci riduciamo a essere “uno”. Diventiamo monolitici, espelliamo parti di noi presenti, parti emotive, relazionali che avrebbero potuto farci capire la diversità di poter essere e poter capire l’altro diverso da me. Così “ognuno di noi racconta una propria “storia ufficiale” tra le tante possibili”, anche se non lo facciamo intenzionalmente, mostriamo di noi le parti più sicure(1), una carta di “identità” presentabile agli altri. Ne ho una verifica personale. Da quando ho cominciato a scrivere la mia storia, in modo discontinuo, viaggiando in tempi lunghi, rileggo ogni volta dall’inizio quanto scritto, e mi accorgo di mancanze presenti, di vuoti incomprensibili che solo dialogando con me stesso nel silenzio della notte riesco a recuperare. Parti di me prima sconosciute o che comunque interrogano e chiedono risposte impossibili, perché non sono più presenti gli altri protagonisti della mia vita. Ma integro con quel poco che riesco a recuperare e sono sempre più convinto che ogni storia è sempre in itinere, non è, e non può essere, una fotografia statica e immodificabile. Panta rei, diceva il filosofo Eraclito, tutto scorre e cambia, così la nostra storia, è un continuo, lento cambiamento, anche se non ce ne accorgiamo.
Ed è grazie a questa nostra elasticità mentale che riusciamo a far entrare in noi, ma soprattutto un uomo che incontra un altro uomo, l’altro di noi invisibile, sconosciuto, dimenticato, trascurato. Che a volte ci permette di fare entrare l’altro che è fuori di noi, lo straniero, il diverso, l’estraneo, il bisognoso che chiede di essere ascoltato.
Se faccio parlare il terapeuta che è in me, mi chiederebbe: Ma tu sei capace di ascoltare l’altro se non sai ascoltare te stesso? E sei capace di accogliere l’altro diverso da te e lo fai entrare dentro di te con la sua richiesta di aiuto, con il suo io conflittuale, oppositivo, indecifrabile, muto? E dove si apprende l’arte dell’ascolto?
Al terapeuta che è in me risponderei.
Ci sono voluti anni, tanti, e quasi alla fine del percorso per capire che l’altro che chiama, che chiede aiuto, che chiede accoglienza è sempre un diverso da me, e che non è solo un paziente e io non posso essere solo uno psicoterapeuta e che è soprattutto unico. Ognuno di noi è unico e anche il terapeuta che è in me deve essere unico, perchè non può fare affidamento alla sua esperienza accumulata per accogliere e ascoltare quel nuovo unico che chiama e che soffre.
Così scrivevo tempo fa in un altro articolo:
https://www.giuseppebasilepsicoterapeuta.it/congedo-eugenio-borgna/
“Stare di fronte” fino a quando è possibile, se non ci facciamo cambiare correndo “il rischio di insabbiarsi nella palude delle abitudini che gli anni trascinano con sé”(Eugenio Borgna). Il rischio cioè che con l’avanzare dell’età e con l’accumulo delle esperienze e con la certezza supposta di sapere ormai il cosa fare e il come fare. Il rischio di omologare il nuovo, il diverso, l’unico. Adattandolo a quanto ormai si sa, annullando così le differenze, le peculiarità dell’individualità. Perché la verità è che l’individuo è sempre uno sconosciuto, e noi sconosciuti a noi stessi, perchè non siamo i soli ad aver scritto il libro della nostra storia e perché non siamo sempre gli stessi nel corso della vita.
… Conoscere e far conoscere all’altro le sue fragilità è anche un apprendimento di sé, in qualche modo l’altro mi fa da specchio in cui mi vedo non solo capace, ma anche con i miei limiti e le mie fragilità. E di questo ringrazio i miei pazienti per quello che mi hanno dato.
E continuo finché la passione regge e l’età lo permette ”.